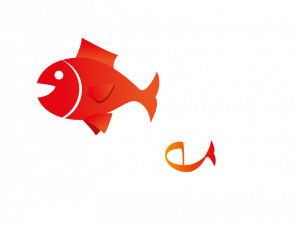Sanihelp.it – Attualmente sull’ADHD non esistono dati definitivi, né in termini diagnostici, né eziologici, né tanto meno terapeutici. Esistono linee guida di diagnosi e trattamento, ma anche in queste è possibile riscontrare dubbi e problemi irrisolti.
Per quanto riguarda la patogenesi sono state avanzate ipotesi riguardanti un’ipofunzione di alcuni sistemi neurotrasmettitoriali in grado di condizionare la difficoltà dei bambini affetti di filtrare, secondo una scala di priorità, gli stimoli esterni, così come sono state ipotizzate alterazioni a livello di alcune proteine cerebrali, cause, o predisposizione, genetiche, e così via. Quindi, anche in ambito biologico le ipotesi non sono del tutto univoche e ciò può indurre lecitamente a sospettare che possa trattarsi di un disturbo a genesi multifattoriale.
Anche i criteri di classificazione comunemente adottati presentano delle differenze, differenze che possono giustificare le discrepanze, talvolta notevoli, riguardanti la prevalenza del disturbo (ad esempio, negli USA questa è stimata in media al 4% adottando i criteri del DSM-IV, mentre in altri paesi che adottano criteri più restrittivi, tipo quelli dell’OMS – ICD 10 – tale percentuale scende all’1-2%) e questo suggerisce l’esistenza di un’eterogeneità anche nosografica.
Su di un altro versante si sono ipotizzati ruoli di fattori ambientali, quali aspetti socio-culturali, eventuali disequilibri nell’entourage scolastico, abusi familiari o persino uno stile di vita igienicamente non corretto condotto dalla madre durante la gravidanza (abuso di alcol o tabacco ecc.).
In sintesi, quindi, il quadro appare talmente multiforme da rendere, a mio parere, una forzatura ricavarne una sorta di etichetta, di paradigma. Cosa che, invece, di fatto è accaduta utilizzando i criteri del DSM-IV, nonostante diverse critiche relative all’utilizzo di un sistema categoriale, basato su criteri di inclusione ed esclusione, per disturbi propri dell’età evolutiva (e quindi magari meglio definibili con approcci evolutivo-dimensionali).
In sostanza, l’idea di un’etichetta diagnostica siffatta e sempre più largamente applicata, non mi trova d’accordo, ritenendo, allo stato attuale delle conoscenze, più funzionale l’adozione di un’attitudine di ragionevole dubbio o di un principio di cautela, nel porre diagnosi, in particolare pensando alle logiche conseguenze del medesimo, ovvero agli approcci terapeutici.
Infatti, questo atteggiamento di elementare prudenza dovrebbe investire soprattutto le condotte terapeutiche, a partire dalla decisione di adottarle o meno, ed in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici: a fronte di un ancor elevato numero di dati incerti i farmaci non dovrebbero essere considerati (e segnatamente dai non addetti ai lavori, vedasi il recente caso della scuola di Milano) l’asse portante delle terapie almeno finché non si potrà disporre di risultati certi, non solo di efficacia, ma anche per quanto concerne il trattamento a lungo termine dell’ADHD e le sue possibili conseguenze.
Questo perché, a fronte di indicazioni riguardanti l’opportunità di trattamenti prolungati, non sono ancora disponibili dati sufficienti a stabilire con certezza la sicurezza di tali trattamenti protratti, anzi, è dato recente la raccomandazione della FDA (il cosiddetto avviso black-box) relativo ai rischi cardiovascolari di terapie con stimolanti adottate nel trattamento dell’ADHD.
Non condanno dunque a priori, ideologicamente, l’uso degli psicofarmaci, che in determinati casi possono rappresentare una scelta terapeutica adeguata, quanto piuttosto la generalizzazione che ne è stata fatta, in particolare negli USA, dove il Ritalin si stava (prima dei recenti provvedimenti restrittivi) avviando a divenire, anche culturalmente, quasi un farmaco da banco.
Il consiglio di massima che rivolgo alle famiglie che si trovano ad affrontare questo problema è di informarsi adeguatamente prima di prendere qualsiasi decisione, confrontando diversi pareri per avere una maggior possibilità di una visione complessiva della questione che non tralasci alcun aspetto e che non sia minata all’interno da interessi secondari, per esempio di tipo commerciale od ambientale.
Gli strumenti e le opportunità esistono: si può fare affidamento ai servizi specialistici, anche territoriali, che si occupano di queste problematiche (e con diverse figure professionali), nonché al pediatra di famiglia e al medico di medicina generale: entrambi conoscono la storia del bambino, della famiglia e possono quindi valutare la situazione con i necessari elementi di giudizio e fornire indicazioni adeguate.